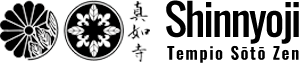A cura di: Paolo Pagli
Seconda conferenza a Shinnyoji del Prof. Paolo Pagli sulla Poesia giapponese nella quale esplora la natura degli Haiku, la loro storia e il rapporto tra Haiku e Zen. La conferenza è stata tenuta il 13 ottobre 2013.
Firenze, Shinnyo-ji 13. 10. 2013
Ringrazio il Maestro per il gentile invito e l’occasione offerta e voi tutti per la presenza e l’attenzione
1. Haiku
Voglio parlare dell’haiku, degli haiku, di come si collocano nella poesia giapponese e nella poesia del mondo.
Ma non so quanti di voi conoscono già gli haiku: tutti probabilmente in questo luogo. Alcuni forse sono degli appassionati che sanno già quello che ora dirò e altro: in tal caso ripercorriamo insieme la via degli haiku e scambiamoci informazioni e riflessioni.
Lo haiku è una forma di composizione poetica del Giappone, di poesia, di 17 sillabe: non versi, né parole, sillabe. Di incredibile brevità quindi: meno di un distico di endecasillabi.. La più breve forma poetica del mondo.
Ma ora “esponiamoci” a degli haiku, ascoltiamoli e viviamoli insieme.
araumi ya Sado ni yokotau Ama no gawa
Mare in tempesta
sopra l’isola di Sado
il Fiume di Stelle
Matsuo Bashō (1644-1694)
misoka tsuki nashi chitose no sugi o daku arashi
Fine del mese, luna nuova
un cedro millenario
abbracciato dalla bufera
Matsuo Bashō
sizukasa ya iwa ni shimiru semi no koe
Tranquillità
il verso di una cicala
penetra la roccia
Matsuo Bashō
[ Seguendo un antico precedente cinese, quasi tutti i dintorni pittoreschi in Giappone hanno le loro otto vedute. Le più famose sono quelle del lago Ōmi, che sono enumerate come segue: la luna di autunno vista da Ishiyama, la neve di sera sullo Hirayama, il tramonto sul Séta, la campana della sera di Miidera, le barche che riapprodano da Yabasa, il cielo splendente con un lieve vento in Awazu, la pioggia di nottetempo a Karasaki e le oche selvatiche che scendono
a Katata. Un uomo di quei posti, dice la tradizione, una volta chiese a Bashô di comporre un haiku che descrivesse le otto vedute. Era un compito apparentemente impossibile data l’estrema brevità della composizione. ]
Sette vedute
sparite nella nebbia
la campana del tempio di Mii
Matsuo Bashō
kare eda ni karasu no tomari keri aki no kure
Sul ramo secco
è posato un corvo
sera d’autunno
Matsuo Bashō
tsuka mo ugoke waga naku koe wa aki no kaze
Scuotiti tomba!
La mia voce desolata
il vento di autunno
Matsuo Bashō
wata torite nebimasarikeri hina no kao
Tolto il cotone
troviamo invecchiate
le facce delle bambole
Takarai Kikaku (1661-1707)
u no hana no taema tatakan yami no mon
Dove finiscono
i fiori di deutzia
una porta di buio
Mukai Kyorai (1651-1704)
ume ga ka no tachinoborite ya tsuki no kasa
Sale fino al cielo
Il profumo dei fiori del pruno –
alone intorno alla luna
Yosa Buson (1716-1783)
zōriya no kite kikoe-keri hatsu-sakura
Il venditore di sandali
è venuto:
i primi fiori di ciliegio
Chiyo-jo (Chiyo-ni) (1703-1775)
daiko hii daiko de micho o oshiekeri
Il raccoglitore di rape
con una rapa
mi indica la strada
Kobayashi Issa (1763-1827)
Susuharai ya kami mo hotoke mo kusa no ue
Grandi pulizie!
Tutti gli dei e i Budda
stesi sull’erba
Masaoka Shiki (1867-1902)
Un albero spoglio
sotto il cielo blu
silenzio della morte
Taneda Santoka (1882-1940)
Tutti insieme
volano in cielo
tempesta di petali!
Takano Sujū (1893-1906)
kawasemi no kage konkon to sakanobori
L’ombra del martin pescatore
continua ad andare
controcorrente
Kawabata Bōsha (1900-1941)
shūya au kikansha ni tsuzuku sharyō nashi
Nella notte di autunno
dietro la locomotiva
nemmeno un vagone
Yamagushi Seishi (1901-1994)
getsumei no hashigo ni koshikake sora kikashi
Mi siedo su una scala
di raggi di luna
il cielo è vicino
Nakamura Kusatao (1901-1983)
nōfu no sō ono ga tsukurishi na no ka sugi
Sepoltura di un contadino
passiamo tra i fiori di rapa
che lui ha piantato
Katō Shūson (1905-1993)
Nello sguardo dell’uccello migratore
divento
sempre più piccolo
Ueda Gosengoku (1933-1997)
yoromekite furimukeba tada aki no kaze
Mi volto
barcollando
solo il vento d’autunno
Koga Mariko (1924- )
aki-kaze ya beni oshiroi mo mi ni furishi
Vento d’autunno
il rossetto e la cipria
mi sembrano vecchi
Okamoto Hitomi (1928- )
Mi tolgo l’anello
rimango con il dito nudo
nel fresco dei fiori
Mayazumi Madoka (1962- )
[“Fresco dei fiori”: kigo di primavera. Indica il ritorno del freddo che di solito segue la fioritura dei ciliegi, prima dell’arrivo del tempo bello primaverile]
* * *
Come vedremo più avanti, l’inutilità e l’impossibilità di commentare gli haiku, da alcuni, viene addirittura teorizzata. Mi limito quindi a qualche confronto per mettere in evidenza la grande variabilità dei registri. Nella raffinatissima critica letteraria giapponese sono state elaborate varie modalità e categorie estetiche specifiche: le utilizzo talvolta senza soffermarmici. Il primo haiku, di Bashō, è un esempio di ogosoka (gravità solenne). A noi colpisce l’ampiezza del quadro che procede dinamicamente in verticale (mare-isola-cielo) e in una travolgente crescita di “stabilità”: il mare mobile, l’isola stabile, la Via Lattea, eterna. Viene in mente la stampa celebre di Hokusai, L’Onda: in quel caso i termini raffigurati sono il mare in tempesta, il Fuji lontano e la zattera con gli uomini: questo elemento umano manca in Bashō, e quasi sempre, negli haiku.
Alla solennità dell’ogosoka, si oppone l’okashii, la lieve ironia comica della composizione di Issa dell’interlocutore e il raccoglitore di rape. Non umoristica ma ugualmente lieve Chiyo-jo segnala una grande notizia, portata dal venditore ambulante di sandali arrivato dal sud: è iniziata la fioritura dei ciliegi!
Analogamente si possono vedere contrapposti la leggerezza, la finezza concentrata in un particolare (osomi) dell’haiku della cicala il cui suono penetra la roccia e l’ampiezza indistinta (futoi) di quello sulle vedute del lago di Ōmi, ambedue di Bashō; la malinconia del passaggio del tempo (sabi), forse la qualità più diffusa negli haiku, e la gioia, (hanayaka: “la fioritura”) del vortice di petali di Suju. Ancora ci sono il sottile senso di mistero (yūgen), per esempio negli haiku di Kyorai (i fiori di deutzia) o di Seishi (il treno nella notte); oppure il pathos per le cose (mono no aware) che lascio ritrovare negli esempi, nonché altro ancora.
Un intero universo espressivo, di incredibile varietà e intensità in una forma minima. Come è nato, quale ne è lo spirito e quale visione del mondo vi inerisce? Quale è il “segreto” di queste composizioni e la forma mentis di chi le ha create?
2. Un destino singolare
A rendere ancora più intensa e pressante la domanda, è emerso negli anni un fatto, imprevedibile e ancora in atto: la popolarità, la diffusione, l’interesse per gli haiku in tutto il primo mondo.
Dalla (forzata) ripresa dei contatti con il Giappone, nel 1854, la cultura giapponese cominciò a diffondersi in Europa e in America: pittura, letteratura, poesia… Uno studioso inglese, Basil Hall Chamberlain, propose le prime traduzioni di poesie e di haiku. A lui risale tra l’altro la presentazione di questi ultimi in tre versi, divenuta fissa in tutte le traduzioni occidentali. Nel seguito, dai primi decenni del ‘900, prima lentamente e poi con rapidità via via crescente dopo la seconda guerra mondiale, l’interesse e l’attenzione per questa forma di poesia è divenuto un elemento della cultura del mondo. Non soltanto si traducono e si leggono haiku, ma si scrivono, seguendone le regole. Cioè autori non giapponesi scrivono, ciascuno nella propria lingua, haiku giapponesi. Ci sono associazioni nazionali di haiku e internazionali, convegni, festival. Il più importante del mondo a Toronto, in Canada.
Nessun’altra forma poetica, di nessuna cultura, ha avuto questo esito.
Questo avviene anche in Italia, anche se in misura minore della Francia, della Germania o il mondo anglosassone. Esiste, non molto attiva, una Associazione Italiana Amici dell’Haiku, a Roma.
3. Storia dell’haiku
3.1 La waka
Torniamo alla domanda: come è quando è nato l’haiku? Si tratta dell’esito di un processo che si snoda lungo quasi nove secoli e che quindi esporrò molto schematicamente.
Già nella prima raccolta di poesie del Giappone, il Manyoshū (Raccolta di diecimila foglie), compare una forma di poesia, un “formato”, denominato wa–ka (poesia giapponese) o tan-ka (poesia breve): il primo nome fa riferimento alla autoctonia (in opposizione alle forme di origine cinese), il secondo alla brevità. La waka si compone di due parti, una di 5-7-5 sillabe, l’altra di 7-7. Questi numeri non sono quasi ulteriormente analizzabili: risultano “consoni” all’eufonia, il ritmo, lo spirito della lingua giapponese e dei suoi suoni. Nel Manyoshū tale forma è già dominante, costituendo quasi il 90% delle composizioni.
La waka ha una vita e una vitalità ininterrotte in Giappone, ed è tuttora praticata. Cito due eventi. Ho qui un libro, da sfogliare nell’intervallo: Michiko, Le chant du gué [Il canto del guado]. Si tratta di una raccolta di waka scritte dall’imperatrice del Giappone, cioè la moglie dell’attuale imperatore Akihito. La f orma “nobile”, alta, della poesia, ha valicato i secoli, dal Manyoshū in poi, e, in tempi più vicino a noi, anche le classi sociali. La prima cerimonia annuale di poesia, per la corte e i nobili, presieduta dall’imperatore stesso, è un evento che data almeno dal XIII secolo: dal 1874, con l’imperatore Meiji, è stato trasformata in un concorso, aperto a tutti, che vede decine di migliaia di partecipanti. Questi inviano la loro waka sul tema che, come in passato, è stabilito in precedenza dall’imperatore. Hirohito, l’imperatore precedente, padre di Akihito, stabilì che la premiazione dei dieci migliori testi fosse trasmessa in televisione: le composizioni vengono cantate alla presenza della famiglia imperiale e della corte.
La waka, resa “sacrale” dal tenno, incarna ancora l’anima poetica del paese. In nessun’altra cultura si ha un analogo esempio di tale intensa, pregnante vitalità
3.2 La renga e l’ haikai no renga
In parallelo con la singolare stabilità di questa forma poetica (non certo però a causa di questa) sussiste il fatto, paradossale in Occidente, della mancanza di composizioni poetiche “lunghe” nella letteratura giapponese. Non ci sono poemi, né poemetti. Non la Divina Commedia, l’ Orlando Furioso, ma nemmeno I Sepolcri (296 v.), o, altrove The Rime of the Ancient Mariner (510 v.), The Waste Land (433 v.), Le Cimetière Marin (144 v.). L’infinito è un “idillio”, cioè una “poesia breve”, ma comunque sono 15 versi, il sonetto ne ha 14.
(Inversamente la prosa produsse, come è noto, a cavallo del 1000, un’opera che oltre ad essere il capolavoro della letteratura giapponese, è un capolavoro della scrittura mondiale, il Genji Monogatari. L’ampiezza, la profondità psicologica e la tenuta sono eguagliati da noi soltanto nel XIX secolo.)
Se mancano le composizioni poetiche “lunghe”, come si è detto, c’è però un singolare evento poetico che è, nel tempo, all’origine dell’haiku.
Molto presto, le due unità della waka, vennero composte, talvolta, da due autori distinti (tan renga, renga corto). Il processo si ampliò a “composizioni a catena” (renga), cioè sequenze di waka
(36 o anche 100, come fu fissato), svolte da più persone che si susseguivano in un’ordine stabilito. Questo già nel XII secolo.
Come si sviluppava la renga? Il primo autore formulava tre versi: la prima “stanza” (ku) della waka. Il secondo completava con i due mancanti; un terzo riproponeva ancora tre versi, un altro due e così via. I partecipanti erano almeno tre, e spesso tre soli, ma in seguito anche cinque.
Di solito, ma non sempre, i primi tre versi erano legati al luogo, al momento specifico, all’occasione: una percezione della realtà. I due successivi tendevano più all’immaginario. Si procedeva per collegamenti labili per noi, analogici, creativi, con frequenti richiami (sottintesi, ma evidenti per i partecipanti) a poesie famose o a personaggi del passato. Ognuno dei partecipanti doveva trovare un nesso col precedente e suggerire a sua volta un’apertura. Non c’erano ripetizioni, ma un progresso continuo. Una creazione collettiva, quindi, ogni personalità in sintonia dinamica con le altre. Una composizione attuata all’istante, che nel risultato ripropone il movimento nel tempo della sua genesi.
La renga era nata come un gioco di aristocratici e letterati. Come in ogni gioco c’erano delle regole da rispettare, che mettevano alla prova l’abilità più che lo spirito poetico. E l’ambiente richiedeva e imponeva un linguaggio raffinato e elevato.
Si rischiò la sterilità, un pericolo che, come vedremo, anche lo haiku, qualche secolo dopo, ha dovuto affrontare. Emerse, come rimedio, la soluzione della renga “libera”, diremmo noi, l’haikai no renga, cioè la renga di haikai. Il termine haikai, che in alcune traduzioni italiane è stato usato erroneamente come sinonimo di haiku (o, talvolta, sembra di capire, come haiku al plurale!), significa propriamente comico, non ortodosso, libero, anche satirico. Ma di fatto, dietro la spinta di personalità poetiche notevoli, l’ haiku no renga non ebbe una deriva nel comico, rimanendo “serio”, ma meno aulico, più libero e senza artifici. Ci furono pure mutamenti “sociali” nella composizione dei partecipanti: prima quasi esclusivamente aristocratica la renga cominciò a diffondersi anche nella borghesia mercantile, in parallelo con altre manifestazioni artistiche. Naturalmente era importante, e divenne fondamentale, la prima stanza della composizione, che doveva essere “germinativa” del seguito, intensa, aperta, radicata nella realtà per sostenere lo sviluppo successivo. Nel XVI e XVII secolo ci furono grandi poeti di renga, nel senso di “direttori” della composizione a catena. Fra questi Sōgi Lio (1421-1502) e poi Bashō, che introdusse anche una forma con un diverso numero di ku: 36.
Ho qui, tradotto in francese, una renga celebre di Sōgi e due altri partecipanti, anch’essi poeti, che è una delle più famose del genere: Trois voix à Minase (Tre voci a Minase). Inutile dire che le renga risultano estremamente difficili per noi lettori occidentali.
3.3 Bashō e l’hokku
È a questo punto, nella seconda metà del 1600, che si inserisce un intervento preciso in questa storia già secolare, quello di Bashō, appunto. Quello che avvenne fu un capovolgimento di ottica: la stanza iniziale della renga diventa autonoma e indipendente. Il nome di questa stanza era hokku, inizio, e esistevano già raccolte di hokku isolati, ma visti sempre come parte iniziale di potenziali haikai no renga. Bashō avvertì che l’ hokku poteva avere la forza di esistere da solo, veicolando già un messaggio proprio, compiuto.
Non c’è al momento (e non ci sarà fino al termine dell’Ottocento: più di due secoli) un nome per questa realtà poetica, ma è nato l’haiku.
Di fatto Bashō dimostrò la realtà degli haiku (cioè la loro possibilità di esistenza e vita), creandoli, lui e la sua scuola. E fissò, implicitamente e esplicitamente, le caratteristiche che diverranno stabili, almeno fino alle discussioni del XX secolo:
a) l’ hokku (l’haiku) è costituito da 17 “misure” (sillabe). Si conferma il rapporto genetico dalla waka. Rare (e volute) le eccezioni: eventualmente l’ipermetropia e non il contrario.
b) nell’haiku compare un termine (kigo) che evoca, in modo univoco, una stagione. La corrispondenza è oggettiva cognitivamente e emotivamente, codificata. Fenomeni astronomici, elementi naturali (fiori, piante, animali), feste civili o religiose, eccellenze estetiche (la luna, senza specifiche, è kigo di autunno, quando, agli occhi giapponesi, è nel massimo splendore). Questo elemento è in generale di quasi totale opacità per noi occidentali, anche quando, come avviene in molte raccolte di haiku tradotti, è indicato esplicitamente a parte.
L’importanza del kigo è decisiva, e, di nuovo, oltre all’opacità del codice di individuazione, anche la pregnanza ci risulta il più delle volte oscura. Durante la guerra, nel 1944, alcuni haijin di Kyoto proposero haiku senza kigo. La reazione fu immediata e tragica: si trattava di un’evidente critica all’imperatore e una propaganda del disfattismo. Ci furono arresti e condanne. Uno studioso giapponese, che mi raccontava l’episodio, non era naturalmente d’accordo con la repressione, ma avvertiva come evidente il collegamento stabilito dall’accusa, per me, per noi, credo, non così chiaro anche dopo la segnalazione.
c) c’è (quasi sempre) una “parola che taglia”, (kireji). I kireji, inesistenti nella nostra lingua, non hanno un connotato semantico, un senso, ma esprimono un’interruzione, questa sì con una valenza semantica. Una separazione o sospensione nel flusso del senso, strutturale, concettuale o emotiva. Un kireji può comparire al termine di uno qualunque dei tre versi. Se è alla fine dell’haiku in qualche modo accentua e colora la chiusura (per esempio, suggerendo una circolarità con l’inizio. Collocato all’interno, spezza il flusso del senso in due parti, ma paradossalmente contribuisce anche a collegarle. Una pausa quindi, ritmica e grammaticale, che investe di una lieve emozione la frase precedente. I kireji più comuni sono almeno 18: ya, keri, kana… Tra l’altro, dal nostro punto di vista, è strano che non si esiti a usare 1 o 2 delle (preziose) 17 sillabe dell’haiku per questo segno di interpunzione appena più intenso reso parola.
La composizione quindi non è un insieme di 17 sillabe validato dalla forza poetica di un’accurata semantica; ha degli elementi fissi e una dinamica strutturale.
Ci sono altri aspetti, più fluttuanti, e ancora più elusivi per noi, per esempio il dosaggio dei kanji presenti nella scrittura, più polisemici della grafia hiragana; poi una serie di qualità di tipo non fisso, tra estetico e gnoseologico, che vengono discusse già negli scritti teorici di Bashō e dei discepoli; essi ritornano almeno nelle variegate interpretazioni critiche e esegetiche dell’haiku.
3.4 Dopo Bashō
La proposta di Bashō, come è noto, trovò un terreno più che fecondo, grazie alla forza del suo esempio e a quella dei suoi discepoli.
Il maestro scomparve appena prima dei 50 anni, ma ormai il seme era gettato.
Gli seguirono, oltre ai discepoli diretti, grandi figure poetiche e per oltre un secolo l’haiku fiorì impetuosamente e rigogliosamente.
Yosa Buson (1716-1784), Chiyo-jo (1703-1776), Kobayashi Issa (1863-1828), per citare solo i più grandi, con i loro haiku, fanno parte ormai della storia della poesia del Giappone e della grande poesia mondiale. Poi ci fu un periodo più sterile e manieristico, nel corso dell’800. Ma nella seconda metà del secolo Masaoka Shiki (1867-1902) rivitalizzò la tradizione, come poeta, del tutto all’altezza dei grandi maestri precedenti, e come teorico e critico. Come ho accennato propose con successo per la composizione il nome haiku, ricavandolo da haikai hokku, hokku dell’ haikai no renga. Incidentalmente fu contrario al renga.
Dopo di lui la tradizione è continuata con ininterrotta vitalità. Si sono formate almeno due correnti: tradizionalisti, per temi e lessico, e innovatori e sperimentali. Ma è storia del ‘900.
4. L’essenza dell’haiku: una proposta di interpretazione
Ha poco senso chiedersi il motivo dell’attrazione della poesia in generale e dell’haiku in particolare: la domanda è troppo grandiosa e difficile. Ma pongo ugualmente la questione e quella che provo a formulare non è una risposta, ma una traccia, una suggestione.
Parto da una composizione poetica italiana che tutti conoscono:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo (1930)
La sua brevità, inusuale nella nostra letteratura, è legata alle correnti poetiche dell’epoca (l’ermetismo), in cui non entro. Superficialmente potrebbe sembrare quasi un haiku, e invece si colloca all’opposto, in un certo senso. Ma lo “scarto” materiale e concettuale fra gli universi poetici soggiacenti, può fornire una maggiore penetrazione proprio riguardo alla natura degli haiku. Tutti i vocaboli presenti nella poesia di Quasimodo, salvo quelli “logici” (il quantificatore “ognuno”, un connettivo) sono usuali e concreti, apparentemente. Ma nessuno è impiegato nel suo senso proprio: il cuore, la terra, il sole, la trafittura, non sono ciò che comporta il significato volta a volta del termine. Sono tutti metafore, costituiscono una catena di metafore reciprocamente connesse che rinviano a un senso generale “altro”, non descrivono un momento o una vicenda, ma definiscono e valutano la condizione umana. Tanta nostra poesia (strutturalmente tutta) è analoga: tensione di un senso che si propaga, diventa universale in un continuo ampliamento metaforico e analogico. Questo aspetto è così pervasivo da risultare implicito e “atteso” dal lettore. Quasi sempre gli eventi, anche se specifici, vogliono essere generali (o passibili di generalizzazione), in un movimento continuo, indefinito, di richiami e di ampliamento della portata.
Nell’haiku avviene il processo opposto. Le metafore sono praticamente inesistenti, le parole individuano unicamente (e esattamente) ciascuno il proprio referente. Certo, i kigo sono segnali (non metafore) con un unico passaggio alla stagione indicata che non ha (non vuole avere) sviluppi. L’haiku presenta, descrive, un accadimento: le parole evocano gli oggetti come si manifestano all’haijin, senza intenzionalità di amplificazioni e risonanze di significato ma in modo essenziale. Lo scenario che l’haiku descrive non è un esemplare (e quindi di per sé inesistente) punto di partenza di un viaggio attraverso strati di senso; l’haiku non è un veicolo immaginale o concettuale che si mette in movimento verso un esterno e un eterno. Rimane, sta e avvolge: è centripeto e non centrifugo. Propone se stesso: un assoluto che provoca un “envoûtement”, un’attrazione che affascina. Il mondo è rifratto negli haiku in atomi di accadimenti che l’haijin coglie e rivela a sé e a noi. L’assenza di pensiero metaforico (e di pensiero tout court) rende ciascuno un quantum di realtà isolato, ma di intensità totale e totalmente appagante.
5. Haiku e Zen
Prima di terminare vorrei esprimere un dubbio, che in questa sede ha una risonanza particolare.
È un luogo comune, in Italia e in Occidente, parlare dello strettissimo rapporto tra haiku e Zen. Lo Zen giapponese inerisce a più Vie, i Do, ma si esprime in modo privilegiato nella visione del mondo che esprimono gli haiku. Alcuni haijin, Bashō, Chiyo-jo furono monaci (e quest’ultima divenne appunto Chiyo-ni, la “monaca” Chiyo).
La posizione è convincente (poesia dell’attimo, uso solo essenziale delle parole, l’accadimento comune portato come rivelazione dell’assoluto), ma mi sembra un po’ vaga. Si arriva a dire che gli haiku sono espressioni dello stato di illuminazione (forse, più propriamente: della tensione verso tale stato); una poesia del satori, risultato di un salto trascendente che può costituire una suggestione a quello stato.
Ma pongo una domanda: il vissuto della natura, la quale è presente e centrale (il kigo!) nell’haiku,
è buddista? O non si richiama piuttosto allo Shintō, la Via degli Dei, alla sua visione della natura in
cui tanti episodi (monti, rocce), sono epifanie del divino?
Non affronto la questione, né sarei in grado, ma pongo una mia difficoltà, precisa.
In effetti pensando a due (grandiose) espressioni dello zen e dello Shintō rispettivamente, i “paesaggi aridi” e i torii, non riesco ad accordarli al mondo, alla mentalità, alla visione e alla tensione degli haiku. Il “giardino” di Ryoān-ji, a Kyoto, e uno dei maestosi tori che conosciamo almeno dalle fotografie, episodi ed esiti, a mio parere, di un processo di astrazione altrettanto profondo, concettualmente e nell’elaborazione, di alcune nostre costruzioni matematiche, come si collegano con l’esperienza, il vissuto e lo stato d’animo della creazione degli haiku?
Lascio aperta la questione.
6. Haiku, ancora
Voglio concludere nel modo in cui ho cominciato: leggendo haiku. Ne propongo ancora due, famosissimi in Giappone e nel mondo. Il primo in particolare è sicuramente il più celebre in assoluto e l’apprezzamento risale già al tempo dell’autore.
furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto
Il vecchio stagno –
una rana salta
tonfo nell’acqua
Bashō
asagao ya tsurube torarete morai mizu
Il convolvolo –
intrecciato alla secchia [del pozzo]
prestito d’acqua
Chiyo-jo
Non commento l’haiku della rana: ognuno può “sentirlo” da sé.
Fu scritto sei anni dopo il “kare eda ni…”, il “corvo sul ramo spoglio”, già citato. Per alcuni commentatori in quell’intervallo di tempo Bashō sarebbe arrivato all’illuminazioe: l’incompiutezza (non estetica!) del corvo diventa la perfezione della rana. Lascio a voi il problema. Sicuramente la tensione del corvo, fermo, come in attesa (insieme al lettore) di un evento che non c’è, si scioglie nello sviluppo dell’azione compiuta della rana, che esprime la sua essenza e quindi quella del mondo.
Del convolvolo (che ho lasciato nella forma scheletrica delle parole dell’originale), emerge una emozione che è il senso e la sintesi della scena: il rispetto. Non la pietà nei confronti di un umile essere vivente, neppure empatia forse, che sarebbe permeata comunque di soggettività: qualcosa di anteriore che si ferma, anche emotivamente, alla soglia dell’ “altro” (un convolvolo!), compagno nella partecipazione all’esistenza e alla vita e nell’esprimersi in essa. Riserbo e una sfumatura di onore reso.
Ricordo, ancora per differenza, una composizione, di straordinaria intensità nei contenuti, della nostra poesia: Il Cantico di Frate Sole, di Francesco d’Assisi. Anche qui rispetto, accettazione, gratitudine, non espressa questa in Chiyo-jo, e neanche implicita, ma non necessaria: nella cultura del Giappone tale gratitudine inerisce alla vita. Ma segnalo una differenza, tra le tante, del Cantico, rispetto all’haiku che “esprime” bene una modalità dell’Occidente. A parte il sole, fisicamente unico nell’universo di Francesco, tutti gli altri elementi citati, il fuoco, l’acqua, sono “collettivi”. Enti materiali, certo, ma indicati ciascuno come una classe di enti, e quindi già tramite un’astrazione. L’essere, come sempre da noi, a differenza del semplice, unico, specifico esistente proposto da Chiyo-jo.
7. Conclusione
Gli haiku, e gli haijn offrono un punto di vista che è una conoscenza che non conoscevamo, una visione di noi e un vissuto della bellezza che non supponevamo.
Ci danno il piacere intenso della poesia, sostegno eterno alla fragilità del nostro essere del mondo e un’informazione in più su noi stessi-
Di questo siamo grati a gli haijin e al Giappone.
Grazie dell’attenzione
Cenno bibliografico
Mario Riccò, Paolo Lagazzi (a cura di), Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, BUR, Rizzoli, Milano, 1996, pp. 419.
L’opera tratta tutta la poesia giapponese, e non soltanto gli haiku, comunque largamente presenti. Per la buona resa nella nostra lingua e il preciso apparato rappresenta ancora il testo più efficace per introdursi al mondo poetico giapponese.
Elena Dal Pra (a cura di), Haiku. Il fiore della poesia giapponese da Bashō all’Ottocento, Oscar Classici, Mondadori, Milano, 1998, pp. 270.
Sintetico, quasi senza note, intenso.
Irene Starace (a cura di), Il grande libro degli haiku, Castelvecchi, Roma, 2005, pp. 1518.
La più ampia raccolta di haiku esistente in italiano, con oltre due terzi dei testi dedicati ad autori del ‘900.
Le edizioni Empiria (Roma) hanno pubblicato vari testi di poesia giapponese e di haiku, anche di autori italiani. Nelle edizioni Marsilio (Venezia) sono stati pubblicati, in tre piccoli libri, i diari di viaggio di Bashō, che contengono vari hokku. Le edizioni La Vita Felice (Milano) hanno in catalogo varie raccolte di haiku di autori “classici” singoli (Bashō, Buson, Issa, Shiki, Ryokān) e anche del ‘900 (Akugatagawa).